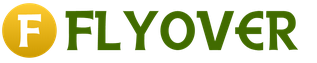La temperatura corporea degli esseri umani e degli animali più alti viene mantenuta a un livello relativamente costante, nonostante le fluttuazioni della temperatura ambiente. Questa costanza della temperatura corporea è chiamata isotermia.
L'isotermia è caratteristica solo dei cosiddetti animali omeotermici oa sangue caldo. L'isotermia è assente negli animali poichilotermici, oa sangue freddo, la cui temperatura corporea è variabile e differisce poco dalla temperatura ambiente.
L'isotermia si sviluppa gradualmente durante lo sviluppo dell'organismo. In un neonato, la capacità di mantenere una temperatura corporea costante è debole. Di conseguenza, il raffreddamento (ipotermia) o il surriscaldamento (ipertermia) del corpo possono verificarsi a temperature ambiente che non interessano un adulto. Inoltre, anche un piccolo lavoro muscolare, come quando un bambino urla a lungo, può aumentare la temperatura corporea.
La temperatura è uno dei fattori più importanti che determinano la velocità e la direzione delle reazioni chimiche. L'essenza del metabolismo - il segno principale e integrale della vita - sono le reazioni enzimatiche chimiche. Pertanto, la temperatura è una delle costanti più importanti del corpo, che viene mantenuta a un livello strettamente costante. La temperatura di organi e tessuti, così come dell'intero organismo nel suo insieme, dipende dall'intensità della produzione di calore e dalla quantità di calore trasferito.
La produzione di calore si verifica come risultato di reazioni esotermiche che si verificano continuamente. Queste reazioni si verificano in tutti gli organi e tessuti con vari gradi di intensità. Nei tessuti e negli organi che svolgono un lavoro attivo - nel tessuto muscolare, fegato, reni, viene rilasciato più calore che in meno attivi - tessuto connettivo, ossa, cartilagine.
Il trasferimento di calore è il trasferimento di calore all'ambiente, avviene costantemente e contemporaneamente al processo di produzione del calore.
La perdita di calore si verifica in diversi modi. Come ogni corpo riscaldato, il corpo emette calore per irraggiamento. In condizioni in cui la temperatura ambiente è inferiore alla temperatura corporea, il calore viene rilasciato per convezione - riscaldamento dell'aria o degli oggetti con cui il corpo viene a contatto. Infine, il trasferimento di calore viene effettuato per evaporazione dell'acqua - sudore dalla superficie del corpo. Parte del calore viene perso attraverso l'aria espirata, l'urina e le feci.
La temperatura dei diversi organi è diversa. Quindi, il fegato, situato in profondità all'interno del corpo e dando una maggiore produzione di calore, ha una temperatura più alta e costante nell'uomo (37,8-38 ° C) rispetto alla pelle, la cui temperatura è molto più bassa (nelle zone coperte dai vestiti, 29,5-33, 9 ° C) ed è più dipendente dall'ambiente. Inoltre, diverse parti della superficie della pelle hanno temperature diverse. Di solito la temperatura della pelle del tronco e della testa (33-34 ° C) è superiore alla temperatura delle estremità. Da quanto sopra consegue che il concetto di "temperatura corporea costante" è condizionato. Soprattutto, la temperatura media del corpo nel suo insieme è caratterizzata dalla temperatura del sangue nei vasi più grandi, poiché il sangue che circola in essi si riscalda nei tessuti attivi (raffreddandoli così) e si raffredda nella pelle (riscaldandola contemporaneamente).
La temperatura corporea di una persona viene solitamente giudicata sulla base della sua misurazione sotto l'ascella. Qui, la temperatura in una persona sana è di 36,5 -36,9 ° C. In clinica, la temperatura nel retto viene spesso misurata (soprattutto nei neonati), dove è più alta che sotto l'ascella, ed è pari alla temperatura in una persona sana in media 37,2-37,5 ° C.
La temperatura corporea non rimane costante, ma oscilla durante il giorno nell'intervallo 0,5-0,7 ° C. Il riposo e il sonno abbassano la temperatura, l'attività muscolare la aumenta. La temperatura corporea massima si osserva alle 16:00, quella minima alle 3-4:00.
La costanza della temperatura corporea in una persona può essere mantenuta a condizione che la produzione di calore e il trasferimento di calore dell'intero corpo siano uguali. Ciò si ottiene attraverso meccanismi fisiologici di termoregolazione. La termoregolazione si manifesta sotto forma di una combinazione di processi di produzione di calore e trasferimento di calore, regolati dalla via neuroendocrina. La termoregolazione è solitamente suddivisa in chimica e fisica.
La termoregolazione chimica viene eseguita modificando il livello di generazione di calore, ad es. rafforzare o indebolire l'intensità del metabolismo nelle cellule del corpo. La termoregolazione fisica viene effettuata modificando l'intensità del rilascio di calore.
Un aumento della produzione di calore con un termogono contrattile è dovuto ad un aumento dell'attività del tessuto muscolare. Quando i muscoli scheletrici volontari si contraggono, la produzione di calore aumenta. Esiste un tipo speciale di contrazione muscolare: tremori muscolari, in cui i muscoli non svolgono un lavoro utile e la loro contrazione è finalizzata esclusivamente a generare calore.
Con la termogenesi non restringente, il corso delle reazioni chimiche cambia. Non tutta l'energia rilasciata nei processi di dissimilazione è contenuta nella molecola di ATP. Il numero di molecole di ATP sintetizzate diminuisce, perché parte dell'energia si trasforma immediatamente in calore. Il corpo si riscalda, ma le sue capacità di lavoro sono ridotte. La termoregolazione chimica basata sui cambiamenti del metabolismo è troppo costosa per mantenere una temperatura corporea costante.
La termoregolazione chimica è fondamentale per mantenere una temperatura corporea costante, sia in condizioni normali che al variare della temperatura ambiente. I meccanismi di termoregolazione chimica si attivano quando gli organi sono esposti a un raffreddamento prolungato e forte.
Negli esseri umani, c'è un aumento della produzione di calore dovuto ad un aumento del tasso metabolico se la temperatura ambiente scende al di sotto della temperatura ottimale o della zona di comfort. Con normali indumenti leggeri, questa zona è compresa tra 18-20 ° С e per una persona nuda - 28 ° С.
La produzione di calore più intensa nel corpo avviene nei muscoli. Anche se una persona giace immobile, ma con muscoli tesi, i processi ossidativi e allo stesso tempo la produzione di calore aumentano del 10%. Una leggera attività fisica porta ad un aumento della produzione di calore del 50-80% e un lavoro muscolare pesante - del 400-500%.
In condizioni di freddo, la generazione di calore nei muscoli aumenta, anche se la persona è ferma. Ciò è dovuto al fatto che il raffreddamento della superficie corporea, agendo sui recettori che percepiscono l'irritazione da freddo, provoca in modo riflessivo contrazioni muscolari involontarie irregolari, che si manifestano sotto forma di tremori (brividi). In questo caso, i processi metabolici del corpo sono notevolmente migliorati, aumenta il consumo di ossigeno e carboidrati da parte del tessuto muscolare, il che comporta un aumento della produzione di calore.
Nella termoregolazione chimica, oltre ai muscoli, il fegato ei reni giocano un ruolo significativo.
Il rilascio di energia nel corpo avviene a causa della scomposizione ossidativa di proteine, grassi e carboidrati. Pertanto, tutti i meccanismi che regolano i processi ossidativi regolano anche la produzione di calore.
La termoregolazione fisica è apparsa in una fase successiva dell'evoluzione. I suoi meccanismi non influenzano i processi del metabolismo cellulare. I meccanismi di termoregolazione fisica sono inclusi in modo riflessivo e hanno, come ogni meccanismo riflesso, tre componenti principali. In primo luogo, questi sono recettori che percepiscono i cambiamenti di temperatura all'interno del corpo o dell'ambiente. Il secondo anello è il centro di termoregolazione. Il terzo anello sono gli effettori che modificano i processi di trasferimento del calore, mantenendo la temperatura corporea a un livello costante. Nel corpo, ad eccezione della ghiandola sudoripare, non ci sono effettori propri del meccanismo riflesso della termoregolazione fisica.
La termoregolazione fisica è la regolazione del trasferimento di calore. I suoi meccanismi garantiscono il mantenimento della temperatura corporea a un livello costante, sia in condizioni in cui il corpo è minacciato di surriscaldamento sia durante il raffreddamento.
La termoregolazione fisica si effettua alterando il rilascio di calore dal corpo. Acquisisce particolare importanza nel mantenere la costanza della temperatura corporea durante la permanenza del corpo in condizioni di aumento della temperatura ambiente.
Il trasferimento di calore viene effettuato mediante radiazione di calore (trasferimento di calore per radiazione), convezione, cioè movimento e miscelazione dell'aria riscaldata dal corpo, conduzione del calore, ad es. il trasferimento di calore da parte di una sostanza a contatto con la superficie del corpo. La natura del trasferimento di calore da parte del corpo cambia a seconda dell'intensità del metabolismo.
La perdita di calore è impedita dallo strato di aria calma tra i vestiti e la pelle, poiché l'aria è un cattivo conduttore di calore. Lo strato di tessuto adiposo sottocutaneo impedisce in modo significativo il trasferimento di calore a causa della bassa conduttività termica del grasso.
La temperatura della pelle, e quindi l'intensità della radiazione del calore e della conduzione del calore, può cambiare in condizioni fredde o calde dell'ambiente esterno a seguito della ridistribuzione del sangue nei vasi e con una variazione del volume del sangue circolante.
Al freddo, i vasi sanguigni della pelle, principalmente arteriole, si restringono; più sangue entra nei vasi della cavità addominale e quindi il trasferimento di calore è limitato. Gli strati superficiali della pelle, ricevendo meno sangue caldo, emettono meno calore, quindi il trasferimento di calore è ridotto. Inoltre, con un forte raffreddamento della pelle, vengono aperte le anastomosi artero-venose, il che riduce la quantità di sangue che entra nei capillari e quindi impedisce il trasferimento di calore.
La ridistribuzione del sangue che avviene al freddo - una diminuzione della quantità di sangue che circola attraverso i vasi superficiali e un aumento della quantità di sangue che passa attraverso i vasi degli organi interni - contribuisce alla conservazione del calore negli organi interni, la cui temperatura viene mantenuta a un livello costante.
Quando la temperatura ambiente aumenta, i vasi della pelle si espandono, la quantità di sangue che circola in essi aumenta. Il volume di sangue circolante in tutto il corpo aumenta anche a causa del trasferimento di acqua dai tessuti ai vasi, nonché perché la milza e altri depositi di sangue gettano ulteriore sangue nel flusso sanguigno generale. Un aumento della quantità di sangue che circola attraverso i vasi della superficie corporea favorisce il trasferimento di calore per irraggiamento e convezione. Per mantenere una temperatura corporea costante a temperature ambiente elevate, è importante anche la sudorazione, che si verifica a causa del trasferimento di calore nel processo di evaporazione dell'acqua.
Le reazioni regolatorie che mantengono una temperatura corporea costante sono atti riflessi complessi che si verificano in risposta alla stimolazione della temperatura dei recettori.
I recettori da cui si innescano i meccanismi riflessi della termoregolazione chimica e fisica sono suddivisi in recettori che rispondono ai termocettori del caldo e del freddo, o del caldo e del freddo. Si trovano sia sulla superficie che all'interno del corpo. Dalla superficie, i termocettori della pelle sono particolarmente importanti, dall'interno - i termocettori dell'ipotalamo.
Il meccanismo centrale del sistema termoregolatore è costituito da una serie di parti del sistema nervoso centrale, dal midollo spinale alla corteccia cerebrale, compresa. Il suo dipartimento principale si trova nell'ipotalamo ed è suddiviso in un centro di produzione di calore e un centro di trasferimento di calore. Gli impulsi provenienti dall'ipotalamo viaggiano lungo percorsi discendenti verso i centri del sistema nervoso autonomo, situati nel midollo allungato e nel midollo spinale, o ai neuroni che innervano i muscoli striati. Quindi, lungo i nervi vegetativo e somatico, l'informazione va agli effettori della termoregolazione: muscoli, ghiandole sudoripare, centri dell'apparato respiratorio e cardiovascolare, modificando le loro funzioni per preservare o donare il corpo. A causa delle connessioni tra le strutture dell'ipotalamo e della ghiandola pituitaria, le strutture centrali di termoregolazione attraverso le ghiandole endocrine in modo neuroumorale possono influenzare l'intensità del metabolismo nelle cellule, aumentando la produzione di calore. Questi sono, ovviamente, meccanismi riflessi per regolare la temperatura corporea. Strette connessioni dei centri ipotalamici con la corteccia cerebrale forniscono una regolazione riflessa condizionata dei processi di termoregolazione, un sottile cambiamento adattativo nell'attività di tutti gli organi coinvolti nella termoregolazione in risposta a vari cambiamenti nell'ambiente esterno.
L'unico proprio effettore - l'esecutore della termoregolazione fisica - è la ghiandola sudoripare. La sudorazione è il meccanismo fisiologico più potente di rilascio del calore, ad es. raffreddamento. Una persona in uno stato di calma perde circa il 20% del calore per evaporazione dell'umidità rilasciata durante la sudorazione e fino all'80% durante il lavoro muscolare. L'intensità del processo di evaporazione dipende da molti fattori: lo stato del corpo, la temperatura ambiente, il movimento dell'aria e l'umidità. L'evaporazione dell'acqua è un fattore importante nella termoregolazione fisica. Oltre all'effettore proprio della ghiandola sudoripare, viene effettuato anche dal rilascio di acqua durante la respirazione e dalla sua evaporazione dalla superficie delle vie respiratorie. Pertanto, il sistema respiratorio è uno degli effettori più importanti della termoregolazione fisica. I cambiamenti nella frequenza e nella profondità dei movimenti respiratori - dispnea termica che si verifica quando il corpo è esposto a temperature elevate - è un meccanismo importante di termoregolazione nell'uomo. Uno degli effettori più importanti della termoregolazione fisica è il sistema cardiovascolare, che risolve i problemi sia del trasferimento di calore che dell'accumulo di calore, e quindi è coinvolto nei processi di termoregolazione e in condizioni che minacciano il corpo di surriscaldamento e raffreddamento. Il calore viene rilasciato nell'ambiente dalla superficie del corpo: pelle, tessuto adiposo sottocutaneo e muscoli parzialmente adiacenti. Cambiare il diametro dei vasi di questi organi porta a una ridistribuzione della quantità di sangue circolante "riscaldato". In condizioni in cui il trasferimento di calore deve essere ridotto, si verifica la vasocostrizione, la quantità di sangue che scorre sulla superficie del corpo diminuisce e il sangue riscaldato, passando attraverso le anastomosi artero-venose, scorre nei vasi degli organi interni. La temperatura della superficie corporea diminuisce e il trasferimento di calore attraverso la radiazione di calore e la convezione diminuisce. In condizioni che richiedono un aumento del trasferimento di calore, la vasodilatazione porta ad un aumento del flusso di sangue "caldo" alla superficie del corpo e il trasferimento di calore aumenta. Allo stesso tempo, anche la sudorazione aumenta in queste condizioni.
1) Introduzione ……………………………………………………………… .3
2) Poichilotermia, eterotermia, omeotermia ……………………… ... 4
3) Principi di regolazione della temperatura corporea, bilancio termico ... ... ... ... ... 5
4) Fisiologia dei temorecettori …………………………………………… 6
5) Centri di termoregolazione …………………………………………… ... 8
a) centri di trasferimento del calore …………………………………………… ... 9
b) centri di produzione di calore ………………………………………… ..10
6) Meccanismi di produzione del calore ………………………………………… ..10
a) termogenesi contrattile ……………………………………… 11
b) termogenesi non contrattile …………………………………… 12
7) Meccanismi di trasferimento del calore …………………………………………… .12
a) conduzione termica ……………………………………………… ... 13
b) irraggiamento termico ………………………………………………… .13
c) convezione ……………………………………………………… ..14
d) evaporazione ……………………………………………………… ..14
8) Metabolismo ……………………………………………………… .16
9) Cibo ……………………………………………………………… .17
10) Conclusione ……………………………………………………… ... 20
11) Elenco della letteratura utilizzata …………………………………… ..23
INTRODUZIONE
Non importa quanto varie siano le forme di manifestazione della vita, sono sempre inestricabilmente legate alla trasformazione dell'energia. Il metabolismo energetico è una caratteristica insita in ogni cellula vivente. I nutrienti ricchi di energia vengono assorbiti e convertiti chimicamente, mentre i prodotti di scarto metabolici a bassa energia vengono rilasciati dalla cellula. Secondo la prima legge della termodinamica, l'energia non scompare e non si ripresenta. Gli organismi devono ricevere energia in una forma accessibile dall'ambiente e restituire una quantità adeguata di energia all'ambiente in una forma meno adatta per un ulteriore utilizzo.
Circa un secolo fa, il fisiologo francese Claude Bernard stabilì che si formano un organismo vivente e un ambiente sistema unificato, poiché tra loro c'è un continuo scambio di sostanze ed energia. Il normale funzionamento del corpo è supportato dalla regolazione dei componenti interni, che richiede un dispendio energetico. L'uso dell'energia chimica nel corpo è chiamato metabolismo energetico: è lui che funge da indicatore delle condizioni generali e dell'attività fisiologica del corpo.
I processi metabolici (o metabolici), durante i quali elementi specifici del corpo vengono sintetizzati dal cibo assorbito, sono chiamati anabolismo; di conseguenza, quei processi metabolici nel corso dei quali gli elementi strutturali del corpo oi prodotti alimentari assorbiti subiscono la rottura sono chiamati catabolismo.
Un organismo vivente produce calore, che viene utilizzato per riscaldare il corpo. La capacità termica specifica del corpo umano (la quantità di calore richiesta per riscaldare il tessuto di 1 ° C) è in media di 0,83 kcal / kg per 1 grado (per l'acqua - 1 kcal / kg per grado). Per aumentare la temperatura corporea di una persona che pesa 70 kg di 1 °, è necessario spendere 58,1 kcal (0,83 70). In media una persona che pesa 70 kg in condizioni di riposo rilascia circa 72 kcal / ora. Pertanto, se non ci fosse un secondo processo - trasferimento di calore, ogni ora i tessuti umani verrebbero riscaldati di 1,24 ° (72: 58,1). Tuttavia, ciò non accade, poiché in condizioni normali a riposo, il tasso di produzione di calore è uguale al tasso della sua perdita. Questo è chiamato bilancio termico, che si basa sui processi di regolazione della produzione di calore e del trasferimento di calore. Insieme, questo si chiama termoregolazione.
POYKILOTERMIA, ETEROTERMIA, OMOIOTERMIA
Nell'evoluzione del sistema di termoregolazione c'è uno stadio più basso in cui la temperatura corporea di un animale dipende principalmente dalla temperatura dell'ambiente: quando diminuisce, scende anche la temperatura corporea e viceversa. Questo stato della temperatura corporea è chiamato poichilotermia e gli animali sono chiamati poichilotermici. La rana è un tipico rappresentante della poichilotermia. In inverno, la temperatura corporea della rana si avvicina allo zero. In questo stato, è ancora capace di lunghi salti, ma non più di 12-15 cm. In estate, la sua temperatura corporea raggiunge i 20-25 ° C e può saltare molto più in là - fino a 1 m. Di solito, in condizioni di bassa temperatura, gli animali poichilotermici cadono in in uno stato di animazione sospesa. Esistono microrganismi per i quali la temperatura ottimale dell'ambiente varia da 0 ° С a meno 60 ° С, ad esempio microbi che vivono nella massa di ghiaccio o, al contrario, microrganismi che possono resistere a temperature ambiente da + 70 ° С a + 120 ° С, ad esempio, germi di primavera calda.
Meccanismi di produzione e trasferimento del calore.
A - il ruolo degli organi nella produzione di calore
B - il ruolo degli organi nel trasferimento di calore
Alcuni animali, ad esempio un pipistrello, roditori, alcune specie di uccelli, ad esempio un colibrì, appartengono al gruppo degli organismi eterotermici: in alcune condizioni sono organismi poichilotermici, in altre sono omeotermici.
I mammiferi appartengono a organismi omeotermici (a sangue caldo) in cui si verifica l'isotermia, o costanza della temperatura corporea. Tuttavia, l'isotermia è di natura relativa: la temperatura dei tessuti situati a non più di 3 cm dalla superficie corporea (pelle, tessuto sottocutaneo, muscoli superficiali), o il guscio, dipende in gran parte dalla temperatura esterna, mentre il nucleo del corpo, cioè il sistema nervoso centrale , gli organi interni, i muscoli scheletrici situati più in profondità di 3 cm, hanno una temperatura relativamente costante, indipendentemente dalla temperatura ambiente. Pertanto, gli animali a sangue caldo hanno un involucro poichilotermico e un "nucleo" o "nucleo" omeotermico.
Organi per la produzione di calore e controllo della produzione di calore.
K - corteccia, Kzh - pelle, CGT - centri dell'ipotalamo, Cdc - centro vasomotore, PM - midollo allungato, C - midollo spinale, Gf - ghiandola pituitaria, TG - ormone stimolante la tiroide, IVS - ghiandole endocrine, Hm - ormoni, M - muscolo , Pt - fegato, Ptr - distesa digestiva, a, b - flusso di impulsi differenziali.
La temperatura media di una persona del cervello, del sangue, degli organi interni è vicina ai 37 ° C. Il limite fisiologico delle fluttuazioni di questa temperatura è di 1,5 °. Un cambiamento della temperatura del sangue e degli organi interni di una persona di 2-2,5 ° C dal livello medio è accompagnato da una violazione delle funzioni fisiologiche e una temperatura corporea superiore a 43 ° C è praticamente incompatibile con la vita umana.
PRINCIPI DI REGOLAZIONE DELLA TEMPERATURA CORPOREA,
EQUILIBRIO TERMICO
La temperatura interna (corporea) è determinata da due flussi: generazione di calore (produzione di calore) e trasferimento di calore (rilascio di calore). In una zona termica neutra o di comfort (a 27-32 ° C), c'è un equilibrio tra produzione di calore e trasferimento di calore. Ad esempio, in condizioni di riposo fisiologico, il corpo produce circa 1,18 kcal / minuto (ovvero circa 70 kcal l'ora) e la stessa quantità di calore viene rilasciata nell'ambiente. A basse temperature ambiente, nonostante il meccanismo di difesa, la perdita di calore del corpo aumenta. In queste condizioni, per mantenere la temperatura corporea, il corpo deve aumentare in modo equivalente la produzione di calore. Quindi, sorge un nuovo livello di equilibrio termico. Ad esempio, ad una temperatura dell'aria di 10 ° C, il trasferimento di calore raggiunge 120 kcal / ora (in condizioni di comfort - 70 kcal / ora), quindi, per mantenere la temperatura corporea a un livello costante, anche la produzione di calore deve aumentare fino a 120 kcal / ora.
quando alta temperatura ambiente, ad esempio, a 40 ° C, il rilascio di calore è notevolmente ridotto, ad esempio, a 40 kcal / ora (invece di 70 kcal / ora in un ambiente confortevole). Per mantenere una temperatura corporea costante, anche la produzione di calore dovrebbe scendere a circa 40 kcal / ora. Viene stabilito un nuovo livello di equilibrio termico, che garantisce il mantenimento della temperatura corporea.
Pertanto, il fattore principale che determina il livello di equilibrio termico è la temperatura ambiente.
Considerando che la produzione di calore cambia a seconda del tipo di attività fisica di una persona e la quantità di trasferimento di calore dipende in gran parte dalla temperatura ambiente, sono necessari meccanismi per regolare la produzione di calore e il trasferimento di calore. Sono eseguiti con la partecipazione di strutture specializzate del cervello, unite al centro della termoregolazione. Il principio di regolazione è che il dispositivo di controllo (centro di termoregolazione) riceve informazioni dai termocettori. Sulla base di queste informazioni, genera tali comandi, grazie ai quali l'attività degli oggetti di controllo (strutture di lavoro che determinano l'intensità della produzione di calore e del trasferimento di calore) cambia in modo che sorga un nuovo livello di equilibrio termico, a seguito del quale la temperatura corporea rimane a un livello costante. Il sistema di termoregolazione può funzionare in modalità di tracciamento o in base al principio del disadattamento: la temperatura del sangue è cambiata, l'attività degli oggetti di controllo cambia. Tuttavia, il sistema di termoregolazione prevede anche un metodo più morbido di mantenimento di una temperatura corporea costante, che si basa sul principio della regolazione per disturbo: viene rilevato un cambiamento della temperatura dell'ambiente e, senza attendere che influenzi la temperatura del sangue, compaiono nel sistema comandi che modificano il funzionamento degli oggetti di controllo in questo modo, che la temperatura del sangue sia mantenuta costante. Inoltre, il sistema di termoregolazione può funzionare anche nella modalità di controllo predittivo, cioè controllo precoce (questi sono riflessi condizionati): una persona sta per uscire per una strada invernale e la sua produzione di calore è già in aumento, il che è necessario per compensare le perdite di calore che si verificheranno in una persona per strada in condizioni di bassa temperatura. In tutti i casi, le informazioni sulla temperatura del corpo (nucleo e guscio) sono necessarie per una regolazione ottimale dell'intensità della produzione di calore e del trasferimento di calore. Viene trasmesso al sistema nervoso centrale dai termocettori.
FISIOLOGIA DEI TERMORECETTORI
I termocettori si trovano su varie parti della pelle, negli organi interni (nello stomaco, nell'intestino, nell'utero, nella vescica), nel tratto respiratorio, nelle mucose, nella cornea dell'occhio, nei muscoli scheletrici, nei vasi sanguigni, comprese le arterie, nelle zone aortiche e carotidi, in molti grandi vene, così come nella corteccia cerebrale, nel midollo spinale, nella formazione reticolare, nel mesencefalo, nell'ipotalamo.
I termocettori del sistema nervoso centrale sono, molto probabilmente, neuroni che agiscono simultaneamente come recettori e svolgono il ruolo di un neurone afferente.
I termocettori della pelle sono stati studiati in modo più completo. La maggior parte dei termocettori si trova sul cuoio capelluto (viso) e sul collo. In media, 1 termocettore cade su 1 mm 2 della superficie della pelle. I termocettori cutanei si dividono in freddo e caldo. A loro volta, quelli freddi si suddividono in quelli effettivamente freddi (specifici), che reagiscono solo agli sbalzi di temperatura, e quelli tattili-freddi, o aspecifici, che possono rispondere simultaneamente sia alle variazioni di temperatura che alla pressione.
I recettori del freddo si trovano a una profondità di 0,17 mm dalla superficie della pelle. Sono circa 250mila in totale. Reagiscono alle variazioni di temperatura con un breve periodo di latenza. In questo caso, la frequenza del potenziale d'azione dipende linearmente dalla temperatura nell'intervallo da 41 ° a 10 ° C: minore è la temperatura, maggiore è la frequenza degli impulsi. La sensibilità ottimale è compresa tra 15 ° e 30 ° С e, secondo alcune fonti, fino a 34 ° С.
I recettori termici si trovano più in profondità, a una distanza di 0,3 mm dalla superficie della pelle. Sono circa 30mila in totale. Reagiscono linearmente alle variazioni di temperatura nell'intervallo da 20 ° a 50 ° C: maggiore è la temperatura, maggiore è la frequenza di generazione del potenziale d'azione. La sensibilità ottimale è compresa tra 34 e 43 ° С.
Tra i recettori del freddo e del calore, ci sono popolazioni di recettori di diversa sensibilità: alcuni reagiscono a un cambiamento di temperatura pari a 0,1 ° С (recettori altamente sensibili), altri - a un cambiamento di temperatura pari a 1 ° С (recettori di media sensibilità), e altri - a un cambiamento di 10 ° C (recettori ad alta soglia o bassa sensibilità).
Le informazioni provenienti dai recettori cutanei arrivano al sistema nervoso centrale attraverso le fibre afferenti del gruppo A-delta e attraverso le fibre del gruppo C; raggiunge il sistema nervoso centrale a velocità diverse. Molto probabilmente, gli impulsi dei recettori del freddo percorrono le fibre A-delta.
L'impulso dai recettori cutanei entra nel midollo spinale, dove si trovano i secondi neuroni, dando origine alla via spinotalamica, che termina nei nuclei ventrobasali del talamo, da dove parte dell'informazione entra nella zona sensomotoria della corteccia cerebrale, e parte di essa va ai centri ipotalamici di termoregolazione.
Le parti superiori del sistema nervoso centrale (corteccia e sistema limbico) forniscono la formazione di sensazione di calore (calore, freddo, comfort termico, disagio termico). La sensazione di comfort si basa sul flusso di impulsi dai termocettori del guscio (principalmente la pelle). Pertanto, il corpo può essere "ingannato": se, in condizioni di alta temperatura, il corpo viene raffreddato con acqua fresca, come nel caso del bagno estivo al caldo, si crea una sensazione di comfort termico.
CENTRI DI REGOLAZIONE TERMICA
La termoregolazione viene eseguita principalmente con la partecipazione del sistema nervoso centrale, sebbene alcuni processi di termoregolazione siano possibili anche senza il sistema nervoso centrale. Quindi, è noto che i vasi sanguigni della pelle possono reagire al freddo: a causa della sensibilità termica delle cellule muscolari lisce al freddo, si verifica il rilassamento della muscolatura liscia, quindi, al freddo, si verifica prima uno spasmo riflesso, che è accompagnato da dolore, e quindi il vaso si espande per effetto diretto del freddo sulle cellule muscolari lisce. Pertanto, la combinazione di due meccanismi di regolazione consente, da un lato, di stare al caldo e, dall'altro, di impedire ai tessuti di soffrire di carenza di ossigeno.
I centri termoregolatori sono, in senso lato, un insieme di neuroni coinvolti nella termoregolazione. Si trovano in varie aree del sistema nervoso centrale, tra cui la corteccia cerebrale, il sistema limbico (complesso dell'amigdala, ippocampo), il talamo, l'ipotalamo, il centro, il midollo allungato e il midollo spinale. Ogni parte del cervello svolge i propri compiti. In particolare, la corteccia, il sistema limbico e il talamo forniscono il controllo sull'attività dei centri ipotalamici e delle strutture spinali, formando un comportamento umano adeguato in varie condizioni di temperatura dell'ambiente (postura di lavoro, abbigliamento, movimento volontario) e sensazioni di calore, freddo o comfort. Con l'aiuto della corteccia cerebrale, viene eseguita una termoregolazione precoce (precoce) - si formano riflessi condizionati. Ad esempio, una persona che sta per uscire in inverno aumenta in anticipo la produzione di calore.
La termoregolazione coinvolge il sistema nervoso simpatico e somatico. Il sistema simpatico regola i processi di produzione di calore (glicogenolisi, lipolisi), processi di trasferimento di calore (sudorazione, trasferimento di calore mediante radiazione di calore, conduzione di calore e convezione - modificando il tono dei vasi cutanei). Il sistema somatico regola la tensione tonica, l'attività di fase volontaria e involontaria dei muscoli scheletrici, cioè i processi di termogenesi contrattile.
L'ipotalamo gioca un ruolo importante nella termoregolazione. Distingue tra gruppi di neuroni che regolano il trasferimento di calore (centro di trasferimento di calore) e la produzione di calore.
Per la prima volta l'esistenza di tali centri nell'ipotalamo fu scoperta da K. Bernard. Ha prodotto una "iniezione di calore" (irritato meccanicamente l'ipotalamo dell'animale), dopo di che la temperatura corporea è aumentata.
Gli animali con nuclei distrutti della regione preottica dell'ipotalamo non tollerano temperature ambiente elevate. L'irritazione di queste strutture con una corrente elettrica porta all'espansione dei vasi sanguigni della pelle, alla sudorazione e alla comparsa di dispnea termica. Questo accumulo di nuclei (principalmente paraventricolare, sopraottico, soprachiasmatico) è chiamato "centro di trasferimento del calore".
Quando i neuroni dell'ipotalamo posteriore vengono distrutti, l'animale non tollera bene il freddo. La stimolazione elettrica di quest'area provoca un aumento della temperatura corporea, tremori muscolari, aumento della lipolisi, glicogenolisi. Si ritiene che questi neuroni siano concentrati principalmente nella regione dei nuclei ventromediali e dorsomediali dell'ipotalamo. L'accumulo di questi nuclei è chiamato "centro di produzione di calore".
La distruzione dei centri di termoregolazione trasforma un organismo omeotermico in un organismo poichilotermico.
Secondo K.P. Ivanov (1983, 1984), ci sono neuroni sensoriali, integranti ed efferenti nei centri di produzione e trasferimento di calore. I neuroni sensoriali percepiscono le informazioni dai termocettori situati nella periferia, così come direttamente dal sangue che bagna i neuroni. KP Ivanov divide i neuroni sensoriali in due tipi: 1) percepire le informazioni dai termocettori periferici e 2) percepire la temperatura del sangue. Le informazioni provenienti dai neuroni sensoriali vengono inviate ai neuroni integratori, dove vengono riassunte tutte le informazioni sullo stato della temperatura del nucleo e del guscio del corpo, cioè questi neuroni "calcolano" la temperatura corporea media. Quindi l'informazione va ai neuroni di comando, in cui il valore corrente della temperatura corporea media viene confrontato con il livello dato. La questione dei neuroni che impostano questo livello rimane aperta. Ma probabilmente ci sono tali neuroni e possono essere localizzati nella corteccia, nel sistema limbico o, più probabilmente, nell'ipotalamo. Quindi, se, come risultato del confronto, viene rivelata una deviazione da un dato livello, allora i neuroni efferenti vengono eccitati: al centro del trasferimento di calore, questi sono i neuroni che regolano la sudorazione, il tono dei vasi della pelle, il volume del sangue circolante e al centro della produzione di calore, questi sono i neuroni che regolano il processo di generazione del calore. Non è ancora chiaro se ogni centro (trasferimento di calore e produzione di calore) è impegnato in "calcoli" e prende decisioni in modo indipendente, o se esiste qualche altro centro separato in cui avviene questo processo.
Centri di trasferimento di calore. Quando i neuroni efferenti del centro di trasferimento del calore sono eccitati, il tono dei vasi cutanei può diminuire. Ciò è dovuto all'effetto dei neuroni efferenti del centro di trasferimento del calore ("vasi cutanei") sul centro vasomotore, che, a sua volta, influenza l'attività dei neuroni simpatici spinali che inviano un flusso di impulsi ai muscoli lisci dei vasi cutanei. Di conseguenza, quando i neuroni ipotalamici dei "vasi cutanei" sono eccitati, il tono dei vasi cutanei diminuisce, il flusso sanguigno cutaneo aumenta e il trasferimento di calore aumenta a causa della radiazione termica, della conduzione del calore e della convezione. L'aumento del flusso sanguigno nella pelle contribuisce anche ad aumentare la traspirazione (perdita di calore per evaporazione). Se il cambiamento nel flusso sanguigno cutaneo è insufficiente per il trasferimento di calore, i neuroni vengono eccitati, il che porta al rilascio di sangue dai depositi di sangue e, quindi, ad un aumento del volume del trasferimento di calore. Se questo meccanismo non contribuisce alla normalizzazione della temperatura, vengono eccitati i neuroni efferenti del centro di trasferimento del calore, che eccitano i neuroni simpatici che attivano le ghiandole sudoripare, questi neuroni dell'ipotalamo possono essere convenzionalmente chiamati "neuroni regolatori del sudore", o neuroni che regolano la sudorazione. I neuroni simpatici che attivano la sudorazione si trovano nelle colonne laterali del midollo spinale (Th 2 -L 2) e i neuroni postgangliari sono localizzati nei gangli simpatici. Le fibre postgangliari che vanno alle ghiandole sudoripare sono colinergiche, il loro mediatore è l'acetilcolina, che aumenta l'attività della ghiandola sudoripare interagendo con i suoi recettori M-colinergici (il bloccante è l'atropina).
Centri di produzione di calore. I neuroni efferenti del centro di produzione di calore possono anche essere suddivisi condizionatamente in diversi tipi, ognuno dei quali attiva il corrispondente meccanismo di produzione di calore.
a) Alcuni neuroni, quando eccitati, attivano il sistema simpatico, a seguito del quale aumenta l'intensità dei processi di generazione di energia (lipolisi, glicogenolisi, glicolisi, fosforilazione ossidativa). In particolare, i nervi simpatici, grazie all'interazione del loro mediatore (norepinefrina) con i recettori beta-adrenergici, attivano i processi di glicogenolisi e glicolisi nel fegato e processi di lipolisi nel grasso bruno.
Allo stesso tempo, quando il sistema nervoso simpatico è eccitato, aumenta la secrezione degli ormoni del midollo surrenale - adrenalina e norepinefrina - che aumentano la produzione di calore nel fegato, nei muscoli scheletrici, nel grasso bruno, attivando la glicogenolisi, la glicolisi e la lipolisi.
b) Nell'ipotalamo sono presenti neuroni efferenti che colpiscono la ghiandola pituitaria e, attraverso di essa, la ghiandola tiroidea: aumenta la produzione di ormoni contenenti iodio (T 3 e T 4) che, possibilmente, a causa della disconnessione dei processi di fosforilazione ossidativa, aumenta il flusso del calore primario, cioè Cioè, sotto la loro influenza, l'accumulo di energia in ATP diminuisce e la maggior parte dell'energia viene dissipata sotto forma di calore.
c) Nel centro ipotalamico di produzione di calore c'è anche una popolazione di neuroni efferenti, la cui eccitazione porta alla comparsa di tono termoregolatore (mentre aumenta il tono nei muscoli scheletrici, per cui aumenta circa il 40-60% nella generazione di calore) o contrazioni di fase del singolo muscolo
fibre, che vengono chiamate "brivido". In tutti questi casi, il comando dai neuroni efferenti dell'ipotalamo viene trasmesso, in definitiva, ai motoneuroni alfa. La via del tremore centrale è via efferentepassando dall'ipotalamo ai motoneuroni alfa attraverso formazioni intermedie, in particolare, attraverso il tetto del mesencefalo (percorso tettospinale) e attraverso il nucleo rosso (tratto rubrospinale). I dettagli di questo percorso non sono ancora chiari.
MECCANISMI DI PRODUZIONE DI CALORE
La fonte di calore nel corpo sono reazioni esotermiche di ossidazione di proteine, grassi, carboidrati e idrolisi dell'ATP. Durante l'idrolisi dei nutrienti, parte dell'energia rilasciata viene accumulata in ATP e parte viene dissipata come calore (calore primario). Quando si utilizza l'energia accumulata in AGF, parte dell'energia viene utilizzata per svolgere un lavoro utile e parte viene dissipata sotto forma di calore (calore secondario). Pertanto, due flussi di calore - primario e secondario - sono prodotti di calore. Ad una temperatura elevata dell'ambiente o al contatto di una persona con un corpo caldo, il corpo può ricevere parte del calore dall'esterno (calore esogeno).
Se è necessario aumentare la produzione di calore (ad esempio, in condizioni di bassa temperatura ambiente), oltre alla possibilità di ricevere calore dall'esterno, sono presenti nell'organismo meccanismi che aumentano la produzione di calore.
Classificazione dei meccanismi di produzione di calore:
1.Termogenesi contrattiva - produzione di calore come risultato della contrazione del muscolo scheletrico:
a) attività volontaria dell'apparato locomotore;
b) tono termoregolatore;
c) tremori muscolari freddi o attività ritmica involontaria dei muscoli scheletrici.
2. Termogenesi non contrattile o termogenesi non tremolante (produzione di calore come risultato dell'attivazione di glicolisi, glicogenolisi e lipolisi):
a) nei muscoli scheletrici (a causa del disaccoppiamento della fosforilazione ossidativa);
b) nel fegato;
c) nel grasso bruno;
d) a causa della specifica azione dinamica del cibo.
Termogenesi contrattile
Con la contrazione muscolare aumenta l'idrolisi dell'ATP e quindi aumenta il flusso di calore secondario, che va a riscaldare il corpo. L'attività muscolare volontaria si verifica principalmente sotto l'influenza della corteccia cerebrale. L'esperienza umana mostra che il movimento è necessario in ambienti a bassa temperatura. Pertanto, si realizzano atti riflessi condizionati, aumenta l'attività motoria volontaria. Più è alto, maggiore è la produzione di calore. È possibile aumentarlo di 3-5 volte rispetto al valore del metabolismo basale. Di solito, con una diminuzione della temperatura dell'ambiente e della temperatura del sangue, la prima reazione è un aumento del tono termoregolatore. Fu identificato per la prima volta nel 1937 negli animali e nel 1952 nell'uomo. Utilizzando il metodo dell'elettromiografia, è stato dimostrato che con un aumento del tono muscolare causato dall'ipotermia, l'attività elettrica dei muscoli aumenta. Dal punto di vista della meccanica della contrazione, il tono ermetico è la microvibrazione. In media, quando compare, la produzione di calore aumenta del 20-45% rispetto al livello iniziale. Con ipotermia più significativa, il tono termoregolatore si trasforma in brivido muscolare freddo. Il tono termoregolatore è più economico dei tremori muscolari. Di solito i muscoli della testa e del collo sono coinvolti nella sua creazione.
Il tremore, o tremore muscolare freddo, è un'attività ritmica involontaria dei muscoli localizzati superficialmente, a seguito della quale la produzione di calore aumenta 2-3 volte rispetto al livello iniziale. Di solito, prima c'è un tremore nei muscoli della testa e del collo, poi - il tronco e, infine, gli arti. Si ritiene che l'efficienza della produzione di calore con tremori sia 2,5 volte superiore rispetto all'attività volontaria.
I segnali provenienti dai neuroni nell'ipotalamo viaggiano attraverso la “via del tremore centrale” (tetto e nucleo rosso) ai motoneuroni alfa del midollo spinale, da dove i segnali vanno ai muscoli corrispondenti, provocando la loro attività. Le sostanze curariformi (miorilassanti), a causa del blocco dei recettori colinergici H, bloccano lo sviluppo del tono termoregolatore e del brivido freddo. Questo viene utilizzato per creare ipotermia artificiale e viene anche preso in considerazione quando si eseguono interventi chirurgici in cui vengono utilizzati miorilassanti.
Termogenesi non contrattile
Viene effettuato aumentando i processi di ossidazione e riducendo l'efficienza della coniugazione della fosforilazione ossidativa. Il luogo principale della produzione di calore sono i muscoli scheletrici, il fegato e il grasso bruno. A causa di questo tipo di termogenesi, la produzione di calore può aumentare di 3 volte.
Nel muscolo scheletrico, un aumento della termogenesi non accorciata è associato a una diminuzione dell'efficienza della fosforilazione ossidativa dovuta al disaccoppiamento di ossidazione e fosforilazione, nel fegato, principalmente attraverso l'attivazione della glicogenolisi e la successiva ossidazione del glucosio. Il grasso bruno aumenta la produzione di calore a causa della lipolisi (sotto l'influenza di influenze simpatiche e adrenalina). Il grasso bruno si trova nella regione occipitale, tra le scapole, nel mediastino lungo i grandi vasi, sotto le ascelle. A riposo, circa il 10% del calore viene generato nel grasso bruno. Con il raffreddamento, il ruolo del grasso bruno aumenta notevolmente. Durante l'adattamento al freddo (tra i residenti delle zone artiche), la massa di grasso bruno e il suo contributo alla produzione totale di calore aumentano.
La regolazione dei processi di termogenesi non contrattile viene effettuata attivando il sistema simpatico e la produzione di ormoni tiroidei (disaccoppiano la fosforilazione ossidativa) e il midollo surrenale.
MECCANISMI DI RILASCIO DEL CALORE
La maggior parte del calore viene generata negli organi interni. Pertanto, il flusso interno di calore deve andare alla pelle per essere rimosso dal corpo. Il trasferimento di calore dagli organi interni avviene per conduzione termica (in questo modo viene trasferito meno del 50% del calore) e convezione, ovvero trasferimento di calore e massa. Il sangue, grazie alla sua elevata capacità termica, è un buon conduttore di calore.
Il secondo flusso di calore è il flusso dalla pelle all'ambiente. Si chiama flusso esterno. Considerando i meccanismi di trasferimento del calore, di solito si intende questo flusso.
Il trasferimento del calore all'ambiente viene effettuato utilizzando 4 meccanismi principali:
1) evaporazione;
2) conduzione del calore;
3) radiazione termica;
4) convezione.
Meccanismi di trasferimento del calore e controllo del calore.
K - corteccia, Kzh - pelle, CGT - centri dell'ipotalamo, Cdc - centro vasomotorio, PM - midollo allungato, Cm - midollo spinale, Gf - ghiandola pituitaria, TG - ormone stimolante la tiroide, IVS - ghiandole endocrine, Hm - ormoni, Ptr - digestivo tratto, Kc - vasi sanguigni, L - polmoni, a, b - flusso di impulsi afferenti.
Il contributo di ciascun meccanismo al trasferimento di calore è determinato dallo stato dell'ambiente e dalla velocità di produzione di calore nel corpo. In condizioni di comfort termico, la maggior parte del calore viene emessa per conduzione del calore, radiazione termica e convezione, e solo il 19-20% - per evaporazione. A temperature ambiente elevate, fino al 75-90% del calore viene emesso a causa dell'evaporazione.
Conduzione di calore è un modo per cedere calore al corpo, che è a diretto contatto con il corpo umano. Più bassa è la temperatura di questo corpo, maggiore è il gradiente di temperatura, maggiore è la velocità di perdita di calore dovuta a questo meccanismo. Di solito, questo metodo di rilascio del calore è limitato agli indumenti e allo spazio aereo, che sono buoni isolanti termici, così come il grasso sottocutaneo. Più spesso è questo strato, minori sono le possibilità di trasferimento di calore al corpo freddo.
Radiazione di calore - trasferimento di calore dalle zone della pelle non coperte dagli indumenti. Succede per onde lunghe radiazione infrarossaPertanto, questo tipo di trasferimento di calore è anche chiamato trasferimento di calore per radiazione. In condizioni di comfort termico dovuto a questo meccanismo, viene ceduto fino al 60% del calore. L'efficienza della radiazione termica dipende dal gradiente di temperatura (più è alto, più calore viene rilasciato), dall'area da cui proviene la radiazione, dal numero di oggetti nell'ambiente che assorbono i raggi infrarossi.
Convezione. L'aria a contatto con la pelle si riscalda e si solleva, al suo posto viene sostituita una porzione "fredda" di aria, ecc. In questo modo, a causa del trasferimento di calore e di massa, fino al 15% del calore viene rilasciato in condizioni di comfort termico.
In tutti questi meccanismi, il flusso sanguigno cutaneo gioca un ruolo importante: quando la sua intensità aumenta a causa di una diminuzione del tono delle cellule muscolari lisce delle arteriole e della chiusura degli shunt artero-venosi, il trasferimento di calore aumenta in modo significativo. Ciò è facilitato anche da un aumento del volume del sangue circolante: maggiore è il suo valore, maggiore è la possibilità di cessione di calore all'ambiente. Con il freddo si verificano processi opposti: il flusso sanguigno cutaneo diminuisce, anche a causa del trasferimento diretto del sangue arterioso dalle arterie alle vene, bypassando i capillari, il volume del sangue circolante diminuisce e la risposta comportamentale cambia: una persona o un animale assume istintivamente una postura "a palla", perché In questo caso l'area di trasferimento del calore è ridotta del 35%, negli animali a questa si aggiunge la reazione - "pelle d'oca" - lifting del pelo della pelle (piloerezione), che aumenta la cellularità della pelle e riduce la possibilità di trasferimento di calore.
Le mani rappresentano una piccola parte della superficie corporea - solo il 6%, ma la loro pelle cede fino al 60% del calore utilizzando il meccanismo del trasferimento di calore secco (radiazione di calore, convezione).
Evaporazione. Il ritorno di calore avviene a causa del dispendio di energia (0,58 kcal per 1 ml di acqua) per l'evaporazione dell'acqua. Esistono due tipi di evaporazione, o traspirazione: traspirazione impercettibile e percettibile.
a) la traspirazione impercettibile è l'evaporazione dell'acqua dalle mucose delle vie respiratorie e dell'acqua che filtra attraverso l'epitelio della pelle (fluido tissutale). Durante il giorno, attraverso le vie respiratorie, evaporano normalmente fino a 400 ml di acqua, ovvero 400x0,58 kcal \u003d 232 kcal / giorno. Se necessario, questo valore può essere aumentato a causa della cosiddetta dispnea termica, che è causata dall'influenza dei neuroni del centro di trasferimento del calore sui neuroni respiratori del tronco cerebrale.
In media, circa 240 ml di acqua filtrano attraverso l'epidermide al giorno. Pertanto, a causa di ciò, vengono fornite 240 0,58 kcal \u003d 139 kcal / giorno. Questo valore non dipende dai processi di regolazione e vari fattori Mercoledì.
Entrambi i tipi di traspirazione impercettibile al giorno consentono di dare (400 + 240) 0,58 \u003d 371 kcal.
b) traspirazione percettibile (cessione di calore per evaporazione del sudore) Mediamente vengono rilasciati 400-500 ml di sudore al giorno ad una temperatura ambiente confortevole, quindi vengono rilasciate fino a 300 kcal. Tuttavia, se necessario, il volume di sudorazione può aumentare fino a 12 L / giorno, cioè sudando, puoi rinunciare a quasi 7000 kcal al giorno. Le ghiandole sudoripare possono produrre fino a 1,5 litri all'ora e, secondo alcune fonti, fino a 3 litri di sudore.
L'efficienza dell'evaporazione dipende in gran parte dall'ambiente: maggiore è la temperatura e minore è l'umidità dell'aria (saturazione dell'aria con vapore acqueo), maggiore è l'efficienza della traspirazione come meccanismo di trasferimento del calore. Al 100% di saturazione dell'aria con vapore acqueo, l'evaporazione è impossibile.
Le ghiandole sudoripare sono costituite da un'estremità, o corpo, e da un condotto del sudore che si apre verso l'esterno attraverso i pori del sudore. Per la natura della secrezione, le ghiandole sudoripare sono divise in eccrine (merocrine) e apocrine. Le ghiandole apocrine si trovano principalmente sotto l'ascella, nella regione pubica, nonché nelle labbra, nel perineo e nell'areola della ghiandola mammaria. Le ghiandole apocrine secernono una sostanza grassa ricca di composti organici. La questione della loro innervazione è oggetto di dibattito: alcuni sostengono che sia simpatico adrenergico, altri credono che sia del tutto assente e la produzione del segreto dipende dagli ormoni del midollo surrenale (adrenalina e norepinefrina).
Le ghiandole apocrine modificate sono le ghiandole ciliari situate nelle palpebre vicino alle ciglia, così come le ghiandole che producono cerume nel canale uditivo esterno e le ghiandole nasali (ghiandole vestibolari). Tuttavia, le ghiandole apocrine non sono coinvolte nell'evaporazione. Le ghiandole sudoripare eccrine, o merocrine, si trovano nella pelle di quasi tutte le aree del corpo. Ce ne sono più di 2 milioni in totale (anche se ci sono persone a cui mancano quasi completamente). La maggior parte delle ghiandole sudoripare si trovano sui palmi e sulle piante dei piedi (oltre 400 per 1 cm 2) e nella pelle del pube (circa 300 per 1 cm 2). Il tasso di sudorazione, così come l'inclusione delle ghiandole sudoripare nell'attività, varia ampiamente nelle diverse parti del corpo.
Chimicamente, il sudore è una soluzione ipotonica: contiene lo 0,3% di cloruro di sodio (quasi lo 0,9% nel sangue), urea, glucosio, aminoacidi, ammonio, piccole quantità di acido lattico. Il pH del sudore varia da 4,2 a 7, in media pH \u003d 6. Peso specifico - 1.001-1.006. Poiché il sudore è un ambiente ipotonico, con una sudorazione abbondante, si perde più acqua dei sali e può verificarsi un aumento della pressione osmotica nel sangue. Pertanto, la sudorazione profusa è irta di cambiamenti nel metabolismo del sale marino.
Le ghiandole sudoripare sono innervate da fibre colinergiche simpatiche: l'acetilcolina viene rilasciata alle loro estremità, che interagisce con i recettori M-colinergici, aumentando la produzione di sudore. I neuroni pregangliari si trovano nelle colonne laterali del midollo spinale a livello Th 2 -L 2, ei neuroni postgangliari si trovano nel tronco simpatico.
Se è necessario aumentare il trasferimento di calore per evaporazione, vengono attivati \u200b\u200bi neuroni della corteccia, il sistema limbico e, principalmente, l'ipotalamo. Dai neuroni ipotalamici, i segnali vanno ai neuroni del midollo spinale e coinvolgono gradualmente varie aree della pelle nel processo di sudorazione: prima il viso, la fronte, il collo, poi il tronco e gli arti.
Esistono vari modi per influenzare attivamente il processo di traspirazione. Ad esempio, molti farmaci antipiretici o antipiretici: l'aspirina e altri salicilati, aumentano la sudorazione e, quindi, la temperatura corporea più bassa (l'aumento del trasferimento di calore avviene attraverso l'evaporazione). Anche le infiorescenze di tiglio, lamponi, foglie di farfara hanno un effetto diaforetico.
METABOLISMO
Il metabolismo è il processo del metabolismo delle sostanze che entrano nel corpo, a seguito del quale da queste sostanze possono essere formate sostanze più complesse o, al contrario, più semplici.
Il corpo umano, come gli organismi di altri rappresentanti del mondo animale e vegetale, è un sistema termodinamico aperto. Un flusso di energia libera fluisce costantemente in esso. Allo stesso tempo, fornisce all'ambiente energia, principalmente svalutata (associata). Grazie a questi due flussi, l'entropia di un organismo vivente (il grado di disordine, caos, degrado) rimane ad un livello (minimo) costante. Quando, per qualche ragione, il flusso di energia libera (negentropia) diminuisce (o aumenta la formazione di energia legata), aumenta l'entropia totale dell'organismo, che può portare alla sua morte termodinamica.
Secondo la termodinamica dei sistemi viventi, la vita è una lotta contro l'entropia, una lotta tra l'ordinamento di un sistema e il degrado. Secondo la nota equazione di Prigogine, l'aumento minimo dell'entropia si verifica se la velocità del flusso negentropico è uguale alla velocità del flusso entropico nel mezzo.
L'energia gratuita per il corpo può provenire solo dal cibo. Si accumula in complessi legami chimici di proteine, grassi e carboidrati. Per rilasciare questa energia, i nutrienti vengono prima idrolizzati e poi ossidati in condizioni anaerobiche o aerobiche.
Nel processo di idrolisi, che viene eseguito in tratto gastrointestinale, viene rilasciata una piccola parte di energia libera (meno dello 0,5%). Non può essere utilizzato per esigenze bioenergetiche, poiché non viene accumulato da macroergenze come l'ATP. Viene convertita solo in energia termica (calore primario), che viene utilizzata dal corpo per mantenere l'omeostasi della temperatura.
Il secondo stadio del rilascio di energia è il processo di ossidazione anaerobica. In particolare, questo metodo rilascia circa il 5% di tutta l'energia libera dal glucosio quando ossidato in acido lattico. Questa energia, però, viene accumulata dal macroerg ATP e viene utilizzata per svolgere lavori utili, ad esempio, per la contrazione muscolare, per il funzionamento della pompa sodio-potassio, ma alla fine si trasforma anche in calore, che si chiama calore secondario.
Fase 3 - la fase principale del rilascio di energia - fino al 94,5% di tutta l'energia che può essere rilasciata nel corpo. Questo processo si svolge nel ciclo di Krebs: ossida l'acido piruvico (un prodotto dell'ossidazione del glucosio) e l'acetil coenzima A (un prodotto dell'ossidazione degli amminoacidi e degli acidi grassi). Nel processo di ossidazione aerobica, l'energia libera viene rilasciata a seguito del distacco dell'idrogeno e del trasferimento dei suoi elettroni e protoni lungo la catena degli enzimi respiratori all'ossigeno. In questo caso, il rilascio di energia non avviene immediatamente, ma gradualmente, quindi, la maggior parte di questa energia libera (circa il 52-55%) può essere accumulata nell'energia del macroerg (ATP). Il resto viene perso come calore primario a causa della "imperfezione" dell'ossidazione biologica. Dopo aver utilizzato l'energia gratuita immagazzinata nell'ATP per svolgere un lavoro utile, si trasforma in calore secondario.
Pertanto, tutta l'energia libera che viene rilasciata durante l'ossidazione dei nutrienti viene infine convertita in energia termica. Pertanto, misurare la quantità di energia termica emessa dal corpo è un metodo per determinare il dispendio energetico del corpo.
Come risultato dell'ossidazione, il glucosio, gli amminoacidi e gli acidi grassi nel corpo vengono convertiti in anidride carbonica e acqua.
Il metabolismo energetico di un organismo animale (metabolismo grossolano) è costituito dal metabolismo di base e da un'aggiunta funzionante al metabolismo di base. Il valore iniziale del livello dei processi metabolici è il metabolismo basale. Le condizioni standard specificate per determinare il metabolismo basale caratterizzano quei fattori che possono influenzare l'intensità dei processi metabolici negli esseri umani. Ad esempio, il tasso metabolico è soggetto a fluttuazioni giornaliere, che aumentano al mattino e diminuiscono di notte. L'intensità del metabolismo aumenta anche con il lavoro fisico e mentale. Il consumo di nutrienti e la loro ulteriore digestione hanno un effetto significativo sul livello del metabolismo, soprattutto se i nutrienti sono di natura proteica. Questo fenomeno è chiamato azione specifica-dinamica del cibo. L'aumento del tasso metabolico dopo aver mangiato cibo proteico può durare per 12-18 ore. Infine, se la temperatura ambiente scende al di sotto della temperatura di comfort, aumenta l'intensità dei processi metabolici. Gli spostamenti verso il raffreddamento portano ad un aumento del metabolismo maggiore rispetto ai corrispondenti spostamenti verso temperature più elevate.
Anche con il pieno e rigoroso rispetto delle condizioni standard, il metabolismo basale nelle persone sane può variare. Questa variabilità è spiegata dalle differenze di età, sesso, altezza e peso corporeo. Di norma, il valore di 4,2 kJ / kg h è considerato un valore approssimativo del tasso metabolico standard (di base); per una persona di 70 kg, il tasso metabolico basale corrispondente è di circa 7100 kJ / giorno (1700 kcal / giorno).
CIBO
La nutrizione è il processo di assimilazione da parte dell'organismo di sostanze necessarie per costruire e rinnovare i suoi tessuti corporei, oltre che per coprire i costi energetici.
In generale, l'evoluzione dei bisogni nutrizionali degli organismi animali ha incluso il processo di limitazione della propria sintesi di un numero di composti con una contemporanea espansione del consumo di alcuni tipi di composti organici. Ciò ha portato all'isolamento di un intero gruppo di sostanze indispensabili per animali superiori e umani, cioè necessarie per il metabolismo, ma non sintetizzate in modo indipendente.
L'uso di prodotti alimentari, costituiti principalmente da composti complessi di origine vegetale o animale, per il fabbisogno energetico o plastico dell'organismo è possibile solo dopo l'idrolisi di questi fondi e la conversione in composti relativamente semplici privi di specificità di specie. Bisogni nutrizionali tipi diversi gli animali sono diversi a seconda delle sostanze alimentari che il corpo è in grado di sintetizzare e di quelle che devono provenire dall'esterno. Tuttavia, la maggior parte delle differenze nei requisiti nutrizionali sono dovute al modo in cui il cibo viene digerito (idrolizzato). Ciò è dovuto al fatto che negli organismi animali superiori i processi metabolici intermedi procedono in modo simile.
Nel metabolismo (metabolismo) e nell'energia si distinguono due processi: anabolismo e catabolismo. L'anabolismo è inteso come un insieme di processi volti a costruire strutture corporee principalmente attraverso la sintesi di complessi materia organica; sotto catabolismo - un insieme di processi di decomposizione di composti organici complessi e l'uso delle sostanze relativamente semplici risultanti nei processi di scambio di energia. L'anabolismo e il catabolismo si basano sui processi di assimilazione e dissimilazione, che sono interconnessi nel corpo e sono equilibrati in un corpo normale.
In generale, i bisogni degli animali sono abbastanza omogenei: hanno bisogno di nutrienti simili nella struttura per lo scambio energetico; in sostanze come amminoacidi, purine e alcuni lipidi per costruire molecole proteiche complesse e strutture cellulari; in catalizzatori speciali del metabolismo e stabilizzatori delle membrane cellulari; in ioni inorganici e composti per i processi fisico-chimici nel corpo e, infine, in un solvente biologico universale - l'acqua - per creare un ambiente per il metabolismo cellulare.
In definitiva, la composizione alimentare di organismi altamente organizzati comprende la materia organica, la stragrande maggioranza della quale è correlata a proteine, lipidi e carboidrati. I prodotti della loro idrolisi - aminoacidi, acidi grassi, glicerina e monosaccaridi - vengono spesi per l'approvvigionamento energetico del corpo. Nei processi di scambio energetico, gli aminoacidi, gli acidi grassi e il monosugar sono interconnessi da percorsi comuni della loro trasformazione. Pertanto, come vettori energetici, le sostanze alimentari possono essere intercambiabili in base al valore energetico (regola isodinamica).
Il valore energetico (calorico) del cibo è stimato dalla quantità di energia termica rilasciata durante la combustione di 1 g della sostanza alimentare (calore fisiologico di combustione), tradizionalmente espressa in chilocalorie o da SI - in joule (1 kcal \u003d 4,187 kJ). I calcoli hanno dimostrato che il valore energetico dei grassi (38,9 kJ / g; 9,3 kcal / g) è il doppio di quello delle proteine \u200b\u200be dei carboidrati (17,2 kJ / g; 4,1 kcal / g). Proteine \u200b\u200be carboidrati hanno lo stesso valore energetico e possono essere sostituiti 1: 1 in rapporto al peso.
Per mantenere uno stato stazionario del corpo, i costi energetici totali devono essere coperti dall'assunzione di sostanze nutritive, che trasportano un equivalente apporto di energia nei loro legami chimici. Se la quantità di cibo in entrata per coprire le spese energetiche non è sufficiente, le spese energetiche sono compensate dalle riserve interne, principalmente grassi. Se la massa del cibo in arrivo in termini di fonti energetiche supera il consumo di energia, il processo di immagazzinamento dei grassi avviene indipendentemente dalla composizione del cibo.
Va comunque sempre ricordato che queste tre fonti energetiche sono anche la materia plastica dell'organismo animale. Pertanto, l'esclusione prolungata di uno dei tre nutrienti dalla dieta e la sostituzione con una quantità energeticamente equivalente di un'altra sostanza è inaccettabile.
CONCLUSIONE
La vita è associata a un continuo dispendio di energia, necessario per il funzionamento del corpo. Dal punto di vista della termodinamica, gli organismi viventi appartengono a sistemi aperti, poiché per la loro esistenza scambiano costantemente sostanze ed energia con l'ambiente esterno. La fonte energetica degli organismi viventi sono le trasformazioni chimiche di sostanze organiche provenienti dall'ambiente. La trasformazione di queste sostanze da complesse a semplici porta al rilascio di energia contenuta nei legami chimici. L'estrazione di energia dai legami chimici viene effettuata principalmente con il consumo di ossigeno molecolare (metabolismo aerobico); l'ossidazione in un certo numero di catene è preceduta dalla scissione anossica (scambio anaerobico).
Il principale accumulatore di energia per il suo utilizzo nei processi cellulari è l'adenosina trifosfato (ATP). Con l'aiuto dell'energia ATP, è possibile sintetizzare proteine, dividere le cellule, mantenere il loro gradiente osmotico, contrazione muscolare, ecc. Secondo la prima legge della termodinamica, l'energia chimica dell'ATP, passando attraverso stadi intermedi, si trasforma infine in calore, che viene perso dal corpo. Pertanto, l'intensità dello scambio energetico del corpo è la somma dell'energia spesa per la funzione dei sistemi cellulari, energia immagazzinata e le sue perdite sotto forma di calore.
La vita di un organismo dipende dal corso delle reazioni chimiche con la conversione di tutti i tipi di energia in calore. La velocità delle reazioni chimiche, e quindi dello scambio energetico, dipende dalla temperatura dei tessuti. Il calore come trasformazione finale dell'energia è in grado di spostarsi da una regione di temperatura più elevata a una regione di temperatura inferiore. La temperatura dei tessuti è determinata dal rapporto tra la velocità di produzione di calore metabolico delle loro strutture cellulari e la velocità di dissipazione del calore risultante nell'ambiente. Di conseguenza, lo scambio termico tra il corpo e l'ambiente esterno è una condizione essenziale per l'esistenza degli organismi animali. Per mantenere la temperatura corporea normale (ottimale), gli organismi animali dispongono di un sistema di regolazione dello scambio termico con l'ambiente.
Gli organismi animali si suddividono in poichilotermici e omeotermici. I poichilotermici (che si trovano ai gradini inferiori della scala filogenetica) hanno meccanismi di termoregolazione imperfetti, ma comunque abbastanza efficaci. Questi meccanismi includono un sistema chimico di compensazione della temperatura, che consente di mantenere uno scambio energetico stabile con variazioni significative della temperatura corporea, la termoregolazione per comportamento (scelta della temperatura ottimale dell'ambiente) e l'isteresi della temperatura (la capacità di catturare il calore dall'ambiente esterno più velocemente di quanto si perde).
L'omeotermia è un'acquisizione successiva dell'evoluzione del mondo animale. Gli uccelli ei mammiferi sono indicati come animali veramente omeotermici, poiché questi animali sono in grado di mantenere una temperatura corporea costante entro 2 ° C e fluttuazioni relativamente ampie della temperatura dell'ambiente esterno.
L'omeotermia si basa su un livello di scambio energetico più elevato rispetto agli animali poichilotermici a causa dell'aumentato ruolo degli ormoni tiroidei, che stimolano il lavoro della pompa del sodio cellulare. L'elevato scambio energetico ha portato alla formazione di meccanismi perfetti per la regolazione dell'energia termica nell'organismo.
Alcuni animali appartengono al gruppo degli organismi eterotermici: in alcune condizioni sono organismi poichilotermici, in altre sono omeotermici.
Per mantenere una temperatura corporea costante, gli animali omeotermici hanno una termoregolazione chimica e fisica. La termoregolazione fisica viene effettuata modificando la conduttività termica dei tessuti tegumentari del corpo (cambiamenti nel flusso sanguigno della pelle, piloerezione, evaporazione dell'umidità dalla superficie del corpo o dalla cavità orale).
La termoregolazione chimica viene effettuata aumentando la produzione di calore nel corpo. Esistono due fonti principali di termoregolazione chimica (generazione di calore regolato): termogenesi contrattile dovuta all'attività volontaria dell'apparato locomotore, tono termoregolatore e tremori muscolari e termogenesi non contrattile dovuta al tessuto adiposo bruno, azione specifica-dinamica del cibo, ecc.
Lo scambio termico è controllato dall'attività dei termorecettori, le cui informazioni vengono inviate al centro di termoregolazione dell'ipotalamo, che controlla le reazioni di termoregolazione chimica e fisica.
L'esposizione prolungata a temperature ambiente alte o basse porta a cambiamenti significativi nelle proprietà del corpo, aumentando la sua resistenza all'azione dei corrispondenti fattori di temperatura.
La costruzione e il rinnovamento dei tessuti del corpo, nonché la copertura del dispendio energetico del corpo, devono essere forniti con un'alimentazione adeguata. Nel metabolismo e nell'energia si distinguono due processi: anabolismo e catabolismo. L'anabolismo è inteso come un insieme di processi volti a costruire strutture corporee principalmente attraverso la sintesi di sostanze organiche complesse. Il catabolismo è un insieme di processi di decomposizione di sostanze organiche complesse al fine di rilasciare energia. L'anabolismo e il catabolismo si basano sui processi di assimilazione e dissimilazione, che sono interconnessi ed equilibrati.
I bisogni nutrizionali degli animali sono abbastanza omogenei: le sostanze necessarie per il metabolismo energetico (proteine, grassi, carboidrati), sostanze per la costruzione di molecole proteiche complesse e strutture cellulari (aminoacidi, purine, lipidi, carboidrati), speciali catalizzatori metabolici (vitamine) e stabilizzatori delle membrane cellulari (antiossidanti) , ioni inorganici e un solvente biologico universale - l'acqua.
Il valore energetico del cibo è determinato dalla quantità di energia termica rilasciata durante la combustione di 1 g della sostanza alimentare (calore fisiologico di combustione).
La nutrizione razionale è intesa come nutrizione che è sufficiente in termini quantitativi e qualitativamente completi. La base di una dieta equilibrata è l'equilibrio, cioè il rapporto ottimale di cibo consumato. Dieta bilanciata dovrebbe includere proteine, grassi e carboidrati in una proporzione di massa, approssimativamente 1: 1: 4. In termini qualitativi, il cibo dovrebbe essere completo, cioè contenere proteine \u200b\u200b(inclusi amminoacidi essenziali), acidi grassi essenziali (la cosiddetta vitamina F), vitamine, la maggior parte delle quali fanno parte di sistemi catalitici e un ampio gruppo di sostanze simili alle vitamine, elementi inorganici e acqua ...
BIBLIOGRAFIA
1) McMury V. Metabolismo umano. M., 1980.
2) Norton A., Edholm O. Man in condizioni di freddo. M., 1957.
3) Corso generale fisiologia dell'uomo e degli animali / a cura di A.D. Nozdrachev. M., 1991. 2.
4) Fondamenti di fisiologia / ed. P. Sterki. M., 1984.
5) Slonim A. D. Evoluzione della termoregolazione. L., 1986.
6) Fisiologia della termoregolazione: Manuale di fisiologia / a cura di K. P. Ivanova. L., 1984.
7) Fisiologia umana / ed. N.A. Agadzhanyan, V.I. Tsirkin. SPb., 1998.
8) Fisiologia umana / ed. R. Schmidt, G. Tevs. M., 1986 T. 4.
Termoregolazione È un processo che garantisce la capacità del corpo di mantenere la temperatura corporea a un certo livello, indipendentemente dalla temperatura ambiente.
Il centro termoregolatore può essere eccitato sia umoralmente (dalla temperatura del sangue che lo attraversa) che riflessivamente (quando irritato dai recettori cutanei del caldo o del freddo). L'eccitazione del centro termoregolatorio attiva tutti i meccanismi termoregolatori: intensità dei processi ossidativi, tono muscolare scheletrico, reazioni vasomotorie, secrezione delle ghiandole sudoripare, movimenti respiratori. L'intensità dei processi ossidativi può cambiare sia attraverso il sistema nervoso autonomo, sia alterando la secrezione di ormoni tiroidei e il midollo surrenale. Cambiamenti nel lavoro muscolare, vasodilatazione o vasocostrizione, secrezione di sudore, cambiamenti nei movimenti respiratori avvengono in modo riflessivo attraverso i centri vasomotore, respiratorio e sudorazione.
Corteccia
Il centro di termoregolazione è, a sua volta, sotto il controllo della corteccia cerebrale. Se un animale è esposto a surriscaldamento in un determinato ambiente e in esso si verificano le corrispondenti reazioni regolatorie, dopo un po 'l'ambiente da solo (senza surriscaldamento) provocherà le stesse reazioni del surriscaldamento. Pertanto, qui si verifica una reazione riflessa condizionata con la partecipazione della corteccia cerebrale.
I limiti di temperatura della vita sono molto ampi. Le spore di molti batteri possono resistere al riscaldamento a 150 ° e alcuni di loro non perdono la loro vitalità a temperature vicine allo zero assoluto. D'altra parte, alcuni ciliati vivono nelle terme di Ischia (Italia) ad una temperatura di circa 85 °. Molto rimane ancora insufficientemente studiato qui. Pesce, insetti e persino mammiferi possono essere congelati e poi scongelati delicatamente. Ad esempio, le carpe sono state congelate a 15 ° sotto lo zero e di nuovo, gradualmente marcendo, riportate in vita, ma congelare almeno un grado sotto i 15 è già fatale per l'animale. Tuttavia, è anche noto che quando gli spermatozoi vengono congelati a una temperatura prossima a meno 200 ° e quando vengono conservati a lungo a questa temperatura, una parte significativa di essi mantiene la normale vitalità e potere fertilizzante.
In questa pagina materiale sugli argomenti:
Negli animali a sangue caldo e nell'uomo (i cosiddetti organismi omeotermici), a differenza degli organismi a sangue freddo (o poichilotermico), la temperatura corporea costante è un prerequisito per l'esistenza, uno dei parametri cardinali dell'omeostasi (o costanza) dell'ambiente interno del corpo.
I meccanismi fisiologici che forniscono l'omeostasi termica di un organismo (il suo "nucleo") sono suddivisi in due gruppi funzionali: meccanismi di termoregolazione chimica e fisica. La termoregolazione chimica è la regolazione della produzione di calore del corpo. Il calore viene costantemente generato nel corpo durante le reazioni redox del metabolismo. Allo stesso tempo, una parte di essa viene data all'ambiente esterno, maggiore è la differenza di temperatura corporea e ambiente. Pertanto, il mantenimento di una temperatura corporea stabile con una diminuzione della temperatura dell'ambiente richiede un corrispondente aumento dei processi metabolici e la conseguente generazione di calore, che compensa la perdita di calore e porta alla conservazione dell'equilibrio termico generale del corpo e al mantenimento di una temperatura interna costante. Il processo di miglioramento riflesso della produzione di calore in risposta a una diminuzione della temperatura ambiente è chiamato termoregolazione chimica. Il rilascio di energia sotto forma di calore accompagna il carico funzionale di tutti gli organi e tessuti ed è caratteristico di tutti gli organismi viventi. La specificità del corpo umano è che un cambiamento nella produzione di calore come reazione a un cambiamento di temperatura rappresenta una reazione speciale del corpo in essi, che non influisce sul livello di funzionamento dei principali sistemi fisiologici.
La produzione specifica di calore termoregolatore è concentrata principalmente nei muscoli scheletrici ed è associata a particolari forme di funzionamento muscolare che non influiscono sulla loro attività motoria diretta. Un aumento della generazione di calore durante il raffreddamento può verificarsi anche in un muscolo a riposo, così come quando la funzione contrattile viene artificialmente disattivata dall'azione di specifici veleni.
Uno dei meccanismi più comuni di produzione di calore termoregolatore specifico nei muscoli è il cosiddetto tono termoregolatore. È espresso da microcontrazioni di fibrille, registrate come aumento dell'attività elettrica di un muscolo esternamente immobile quando viene raffreddato. Il tono termoregolatore aumenta il consumo di ossigeno del muscolo, a volte di oltre il 150%. Con un raffreddamento più forte, insieme a un forte aumento del tono termoregolatore, sono incluse contrazioni muscolari visibili sotto forma di brivido freddo. In questo caso, lo scambio di gas aumenta al 300-400%. È caratteristico che i muscoli non siano uguali in termini di quota nella generazione di calore termoregolatorio.
Con un'esposizione prolungata al freddo, il tipo contrattile di termogenesi può essere sostituito (o integrato) in un modo o nell'altro spostando la respirazione dei tessuti nel muscolo alla cosiddetta via libera (non fosforilante), in cui cade la fase di formazione e la successiva rottura dell'ATP. Questo meccanismo non è associato all'attività contrattile muscolare. La massa totale di calore rilasciata durante la respirazione libera è praticamente la stessa della termogenesi del lievito, ma la maggior parte dell'energia termica viene consumata immediatamente e i processi ossidativi non possono essere inibiti dalla mancanza di ADP o fosfato inorganico.
Quest'ultima circostanza consente di mantenere liberamente per lungo tempo un elevato livello di generazione di calore.
I cambiamenti nell'intensità del metabolismo causati dall'influenza della temperatura ambiente sul corpo umano sono naturali. In un certo intervallo di temperature esterne, la produzione di calore corrispondente allo scambio di un organismo a riposo è completamente compensata dal suo trasferimento di calore “normale” (senza intensificazione attiva). Lo scambio termico tra il corpo e l'ambiente è equilibrato. Questo intervallo di temperatura è chiamato zona termica neutra. Il tasso di cambio in questa zona è minimo. Spesso parlano di un punto critico, implicando un valore di temperatura specifico al quale si ottiene un equilibrio termico con l'ambiente. Teoricamente, questo è vero, ma è quasi impossibile stabilire sperimentalmente un tale punto a causa delle costanti fluttuazioni irregolari nel metabolismo e dell'instabilità delle proprietà termoisolanti delle coperture.
Una diminuzione della temperatura dell'ambiente al di fuori della zona termoneutrale provoca un aumento riflesso del livello di scambio di sostanze e produzione di calore fino a quando il bilancio termico del corpo non viene bilanciato in nuove condizioni. Per questo motivo, la temperatura corporea rimane invariata.
Un aumento della temperatura dell'ambiente al di fuori della zona termoneutrale provoca anche un aumento del livello di metabolismo, che è causato dall'attivazione di meccanismi di attivazione del trasferimento di calore, che richiedono un consumo energetico aggiuntivo per il loro lavoro. Questa forma una zona di termoregolazione fisica, durante la quale anche la temperatura rimane stabile. Al raggiungimento di una certa soglia, i meccanismi per migliorare il trasferimento di calore si rivelano inefficaci, inizia il surriscaldamento e, infine, la morte dell'organismo.
Già nel 1902 Rubner propose di distinguere tra due tipi di questi meccanismi: la termoregolazione "chimica" e quella "fisica". Il primo è associato a un cambiamento nella produzione di calore nei tessuti (stress delle reazioni di scambio chimico), il secondo è caratterizzato dal trasferimento di calore e dalla ridistribuzione del calore. Insieme alla circolazione sanguigna, la sudorazione gioca un ruolo importante nella termoregolazione fisica, quindi la pelle ha una funzione speciale di trasferimento del calore - qui il sangue riscaldato nei muscoli o nel "nucleo" si raffredda, qui si realizzano i meccanismi di sudorazione e sudorazione.
b Nella "norma" la conduzione del calore può essere trascurata, perché la conducibilità termica dell'aria è bassa. La conducibilità termica dell'acqua è 20 volte superiore; pertanto, il trasferimento di calore per conduzione gioca un ruolo significativo e diventa un fattore significativo di ipotermia nel caso di indumenti bagnati, calzini umidi, ecc.
b Trasferimento di calore più efficiente per convezione (ovvero spostamento di particelle di gas o liquidi, miscelando i loro strati riscaldati con quelli raffreddati). Nell'aria, anche in condizioni di riposo, il trasferimento di calore per convezione rappresenta fino al 30% delle perdite di calore. Il ruolo della convezione nel vento o durante il movimento umano aumenta ancora di più.
b Il trasferimento di calore per irraggiamento da un corpo riscaldato a uno freddo viene effettuato secondo la legge di Stefan-Boltzmann ed è proporzionale alla differenza dei quarti gradi della temperatura della pelle (indumenti) e della superficie degli oggetti circostanti. In questo modo, in condizioni di "comfort", una persona nuda cede fino al 45% dell'energia termica, ma per una persona vestita in modo caldo, la perdita di calore per irraggiamento non gioca un ruolo speciale.
b L'evaporazione dell'umidità dalla pelle e dalla superficie dei polmoni è anche un modo efficace di trasferimento del calore (fino al 25%) in condizioni di "comfort". In condizioni di temperature ambiente elevate e attività muscolare intensa, il trasferimento di calore per evaporazione del sudore gioca un ruolo dominante: con 1 grammo di sudore, vengono portate via 0,6 kcal di energia. Non è difficile calcolare la quantità totale di calore perso con il sudore, se si tiene conto che in condizioni di intensa attività muscolare, una persona può erogare fino a 10-12 litri di liquidi in una giornata lavorativa di otto ore. Al freddo, la perdita di calore con il sudore in una persona ben vestita è piccola, ma anche qui è necessario tenere conto del trasferimento di calore dovuto alla respirazione. In questo processo, due meccanismi di trasferimento del calore vengono combinati contemporaneamente: convezione ed evaporazione. La perdita di calore e liquidi con la respirazione è piuttosto significativa, soprattutto con un'intensa attività muscolare in condizioni di bassa umidità atmosferica.
Un fattore significativo che influenza i processi di termoregolazione sono le reazioni vasomotorie (vasomotorie) della pelle. Con il restringimento più pronunciato del letto vascolare, la perdita di calore può diminuire del 70%, con la massima espansione - aumentare del 90%.
Le differenze di specie nella termoregolazione chimica sono espresse nella differenza nel livello del metabolismo principale (nella zona di termoneutralità), nella posizione e nell'ampiezza della zona termoneutrale, nell'intensità della termoregolazione chimica (un aumento del metabolismo con una diminuzione della temperatura del mezzo di 1 "C), nonché nell'intervallo della termoregolazione effettiva. Tutti questi parametri riflettono specificità ecologica delle singole specie e cambia in modo adattivo a seconda della posizione geografica della regione, della stagione dell'anno, dell'altitudine e di una serie di altri fattori ambientali.
Le reazioni regolatorie volte a mantenere una temperatura corporea costante durante il surriscaldamento sono rappresentate da vari meccanismi per migliorare il trasferimento di calore all'ambiente esterno. Tra questi, il trasferimento di calore è molto diffuso e ha un'alta efficienza intensificando l'evaporazione dell'umidità dalla superficie del corpo e (e) dal tratto respiratorio superiore. Quando l'umidità evapora, il calore viene consumato, il che può aiutare a mantenere l'equilibrio termico. La reazione si attiva quando ci sono segni di inizio di surriscaldamento del corpo.
Quindi, i cambiamenti adattativi nello scambio di calore nel corpo umano possono essere mirati non solo a mantenere un alto livello di metabolismo, come nella maggior parte delle persone, ma anche a fissare un livello basso in condizioni che minacciano l'esaurimento delle riserve energetiche.
Come le fluttuazioni dell'ossigeno e del pH, i cambiamenti nella temperatura intracellulare modulano in modo significativo il metabolismo cellulare. Molti enzimi vitali funzionano in un intervallo di temperatura ristretto, che richiede meccanismi appropriati per mantenere l'equilibrio termico.
Il calore viene generato durante il metabolismo. Qualsiasi aumento del metabolismo cellulare (a seguito di un aumento del livello degli ormoni tiroidei, dell'adrenalina o della norepinefrina nel sangue, un aumento del metabolismo basale o durante l'esercizio) aumenta la produzione di calore. Nel corpo umano, il 60% di tutto il calore viene generato nei muscoli, il 30% nel fegato, il 10% in altri organi. Mediamente una persona che pesa 70 kg emette circa 72 kcal / ora in condizioni di riposo, e per aumentare la sua temperatura di 1 ° C bisogna spendere circa 58 kcal.
Bilancio termico - questo è il rapporto tra i processi di produzione di calore, ritenzione di calore e trasferimento di calore, ad es. equilibrio tra sistemi che producono calore e sistemi in cui questo calore viene perso.
Prodotti termici è principalmente il risultato di processi biochimici, trasferimento di caloree ritenzione di calore- principalmente il risultato di processi fisici.
Meccanismi di produzione di calore. La principale quantità di calore nel corpo si forma durante l'ossidazione di proteine, grassi e carboidrati, nonché come risultato dell'idrolisi dell'ATP. In condizioni di bassa temperatura ambiente nel corpo, vengono attivati \u200b\u200bulteriori meccanismi di generazione di calore:
1. Termogenesi contrattile (generazione di calore dovuta alla contrazione dei muscoli scheletrici):
a) attività motoria volontaria;
b) tremori muscolari freddi;
c) tono muscolare freddo (aumento del tono muscolare al freddo).
2. Termogenesi non contrattile (generazione di calore come risultato dell'attivazione di processi catabolici - glicolisi, glicogenolisi, lipolisi). Può essere osservato nei muscoli scheletrici, nel fegato, nel grasso bruno (dovuto all'azione dinamica specifica del cibo).
Meccanismi di trasferimento del calore. Il trasferimento del calore dall'organismo all'ambiente viene effettuato nei seguenti modi (figura):
1) evaporazione - trasferimento di calore dovuto all'evaporazione dell'acqua;
2) conduzione di calore - trasferimento di calore per contatto diretto con aria ambiente fredda (ridotto in presenza di indumenti e grasso sottocutaneo);
3) radiazione di calore - trasferimento di calore dalle zone della pelle non coperte dagli indumenti;
4) convezione - trasferimento di calore dovuto al riscaldamento di strati d'aria adiacenti, sollevando questi strati riscaldati e sostituendoli con porzioni d'aria fredde.
In condizioni di comfort termico (20-22 ° C), la principale quantità di calore viene ceduta per conduzione termica, irraggiamento termico e convezione, e solo il 20% viene disperso per evaporazione. A temperature ambiente elevate, fino all'80-90% del calore viene perso per evaporazione.
La ritenzione del calore è fornita dallo strato di grasso sottocutaneo, dai capelli, dai vestiti e dal mantenimento di una postura in cui la superficie corporea e i processi di trasferimento del calore sono minimi. Negli animali a sangue caldo, la temperatura viene mantenuta costante. In questo caso, ci sono 2 zone per mantenere la temperatura corporea: omeotermico"Core" o "core", dove la temperatura è davvero mantenuta costante e poichilotermico"Guscio": tutti i tessuti situati a non più di 3 cm dalla superficie del corpo (pelle, tessuto sottocutaneo, ecc.), La cui temperatura dipende in gran parte dalla temperatura ambiente. Per determinare la temperatura corporea media, usa la formula Barton:
T corpo \u003d 2/3 T core + 1/3 T shell.

Immagine. (Ruff, 2001)
Negli esseri umani, la temperatura media del cervello, del sangue, degli organi interni si avvicina a 37 o C. Il limite fisiologico delle sue fluttuazioni è di 1,5 o C. La temperatura corporea di oltre 43 o C è praticamente incompatibile con la vita umana. Esiste circadiano, cioè fluttuazioni circadiane della temperatura corporea entro 1 ° C. La temperatura minima si osserva nelle prime ore del mattino, la massima - nel pomeriggio.
Ad una temperatura confortevole (20-22 ° C) dell'ambiente, viene mantenuto un certo equilibrio tra produzione di calore e trasferimento di calore. A una temperatura ambiente inferiore a 12 ° C, la ritenzione di calore aumenta e, di conseguenza, la produzione di calore, a una temperatura ambiente superiore a 22 ° C, prevalgono i processi di trasferimento del calore e la produzione di calore diminuisce.
Centri di termoregolazione sono nell'ipotalamo. Nell'ipotalamo anteriore - i centri di trasferimento del calore, nella parte posteriore - i centri di produzione di calore.

I termocettori si trovano nella pelle, nei visceri, nel tratto respiratorio, nei muscoli scheletrici e nel sistema nervoso centrale. La maggior parte dei termocettori si trova nel cuoio capelluto e nel collo. Ci sono termocettori del freddo e del calore. Comprensivo sistema nervoso regola i processi di produzione di calore (glicogenolisi, lipolisi) e trasferimento di calore (sudorazione, alterazioni del tono dei vasi cutanei, ecc.). Il sistema somatico regola la tensione tonica, l'attività volontaria e involontaria dei muscoli scheletrici, ad es. processi di termogenesi contrattile.
Ipertermia si verifica a una temperatura ambiente superiore a 37 0 С (specialmente con elevata umidità dell'aria) o con una generazione di calore troppo intensa nel corpo durante un duro lavoro fisico. Allo stesso tempo, nella prima fase (compensata), i vasi periferici si espandono, la sudorazione aumenta, la respirazione diventa più frequente, il che aiuta a rimuovere il calore in eccesso. Nella seconda fase (anche in grado di compensare), nonostante l'aumento del trasferimento di calore, la temperatura corporea aumenta, la respirazione e il polso diventano più frequenti e la testa inizia a far male. Il terzo stadio (non compensato) è caratterizzato da un calo della pressione sanguigna, rallentamento della respirazione, scomparsa dei riflessi e persino morte.
Ipotermia si verifica quando l'equilibrio tra la produzione di calore e il trasferimento di calore è disturbato con una predominanza del trasferimento di calore. Molto spesso, l'ipotermia si sviluppa a causa dell'ipotermia a basse temperature ambiente. L'intossicazione da alcol, la mancanza di movimento muscolare e l'esaurimento facilitano lo sviluppo dell'ipotermia. Nella prima fase dell'ipotermia, la produzione di calore nel corpo aumenta (a causa di tremori muscolari e aumento del metabolismo) e diminuisce il trasferimento di calore (a causa di spasmi dei vasi periferici, diminuzione della sudorazione), ecc. Nella seconda fase (scompensata), la temperatura corporea scende, le funzioni cerebrali sono inibite, la pressione sanguigna scende. Il ripristino delle funzioni corporee è possibile solo se la temperatura corporea è scesa a 24-26 0 С, ma non inferiore.